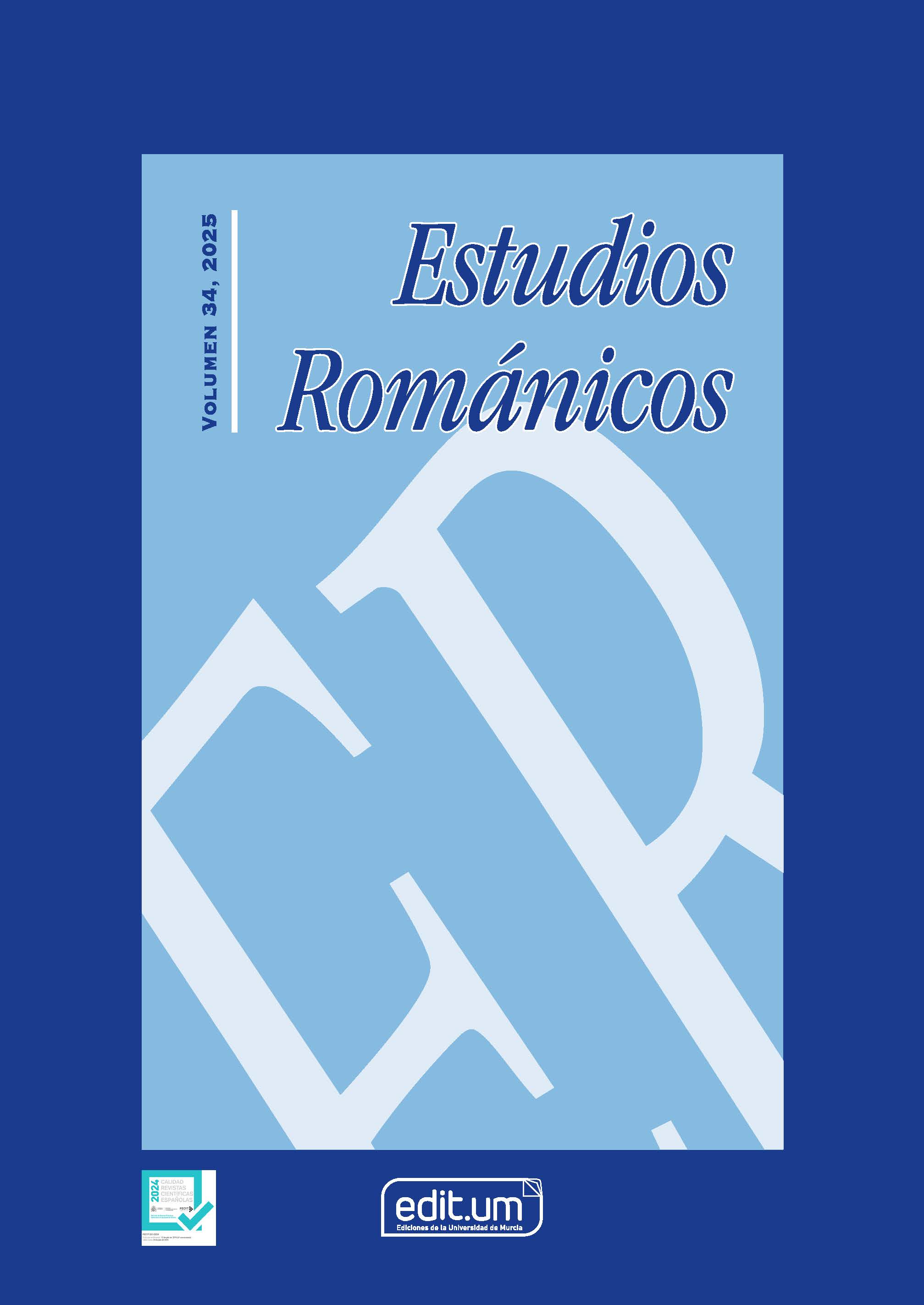Pasolini tal friúl. Un’indagine variantistica sulle poesie in friulano di Pier Paolo Pasolini
Agencias de apoyo
- Masaryk University of Brno
Resumen
Nel 1942, un giovanissimo Pier Paolo Pasolini dà alle stampe a sue spese la sua prima silloge poetica: Poesie a Casarsa. L’esordio, tuttavia, non avviene in italiano, bensì in dialetto: il friulano, la lingua della madre del poeta. La raccolta, divenuta una sezione – la prima – nelle edizioni successive del corpus della poesia friulana di Pasolini, attraversa l’intera produzione pasoliniana, scandendo simbolicamente tre snodi epocali della sua esistenza: la scoperta della poesia e del mondo friulano (Poesie a Casarsa, 1942), l’inizio dei problemi giudiziari che lo portano al trasferimento a Roma (La meglio gioventù, 1954) e gli ultimi, dolorosi, anni (La nuova gioventù, 1975). L’articolo illustrerà uno spoglio parziale dell’indagine variantistica in corso di svolgimento e dedicata alla sezione “Poesie a Casarsa”, il gruppo di liriche che percorrono l’intera produzione friulana di Pasolini e che, pertanto, mostrano in maniera più estesa e chiara il lavoro di revisione condotto dall’autore nell’arco della sua intera vita. Nucleo originale dell’esperienza poetica pasoliniana e, al contempo, raccolta più rimaneggiata, “Poesie a Casarsa” è quindi un sensibile diapason che risponde con precisone alle sensibili oscillazioni stilistiche e ideologiche del suo autore.
Descargas
Citas
Cadorini, G. (2020). Il friulano e i Friulani. In Minoranze linguistiche in Italia (seminář vedený Caroline Bacciuovou), Seminar für Romanische Philologie. Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen online.
Ciliberto, M. (2013). Contini, Croce, gli “scartafacci”. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, 5(2), 571-597.
Contini, G. (1943). Al limite della poesia dialettale. Corriere del Ticino.
Contini, G. (1970). Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi 1938-1968. Einaudi.
Brevini, F. (1979). La lingua che più non si sa: Pasolini e il friulano. Belfagor, 34(4), 397-409.
Ellero, G. (2004). Lingua poesia autonomi 1941-1949. Il Friuli autonomo di Pier Paolo Pasolini. Istitût Ladin Furlan.
Gramsci, A. (1975). Quaderni dal carcere. Einaudi.
Heinemann, S. e Melchior, L. (2015). Manuale Di Linguistica Friulana. De Gruyter.
Infurna, M. (1985). Pasolini e la Provenza. Studi Novecenteschi, 12(29), 121-130.
Isella, D. (1987). Le carte mescolate. Esperienze di filologia d’autore. Liviana editrice.
Italia, Paola e Raboni, G. (2010). Che cos’è la filologia d’autore. Carocci.
Pasolini, P. P. (1942). Poesie a Casarsa. Libreria Antiquaria Mario Landi.
Pasolini, P. P. (1954). La meglio gioventù. Sansoni.
Pasolini, P. P. (1962). Il sogno di una cosa. Garzanti.
Pasolini, P. P. (1972). Empirismo eretico. Garzanti.
Pasolini, P. P. (1975). La nuova gioventù. Einaudi.
Pasolini, P. P. (1976). I Turcs tal Friúl. Forum Julii.
Perusini, G. (1942). Demologia militare. Usi e consuetudini dei coscritti friulani. Ce fastu? – Bollettino della società filologica friulana, 29, 31 dicembre.
Santato, G. (2009). “Paesaggio simbolico e paesaggio poetico nel Friuli di Pier Paolo Pasolini”. In Lisa El Ghaoui. (Ed.). Pier Paolo Pasolini. Due Convegni di studio (Université Stendhal, Grenoble 3, 23-24 maggio 2007 e 3-4 aprile 2008) (pp. 95-114). Fabrizio Serra Editore.
Volpato, S. (2022). Incunaboli di Pasolini. Le edizioni friulane 1942-1953 nella biblioteca di Bruno Lucci. Ronzani editore.
- 31-01-2025 (2)
- 30-01-2025 (1)
Derechos de autor 2025 Estudios Románicos

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Las obras que se publican en esta revista están sujetas a los siguientes términos:
1. El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia (la editorial) conserva los derechos patrimoniales (copyright) de las obras publicadas, y favorece y permite la reutilización de las mismas bajo la licencia de uso indicada en el punto 2.
2. Las obras se publican en la edición electrónica de la revista bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España (texto legal). Se pueden copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente, siempre que: i) se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial y URL de la obra); ii) no se usen para fines comerciales; iii) se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso.
3. Condiciones de auto-archivo. Se permite y se anima a los autores a difundir electrónicamente las versiones pre-print (versión antes de ser evaluada) y/o post-print (versión evaluada y aceptada para su publicación) de sus obras antes de su publicación, ya que favorece su circulación y difusión más temprana y con ello un posible aumento en su citación y alcance entre la comunidad académica. Color RoMEO: verde.